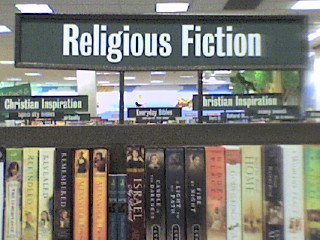interesse 5 su 5
Hans
Ha vissuto novant’anni della più bella e romanzesca esistenza che mi venga in mente. S’è guadagnato la sua voce su Wikipedia – e che volete di più, dalla vita? – finendo sulla lista nera dei nemici di Nixon durante gli anni della guerra in Vietnam, assieme a gente come Gregory Peck, Steve McQueen, e Jane Fonda. Lui, però, ha sempre preferito la compagnia della sua Herta.
Hans era nato in Germania, da una famiglia ebrea, nel settembre del 1920. Lì assistette alla salita al potere del Nazismo e fu uno dei pochi che riuscì a scappare nell’aprile del ’37, dopo che suo padre era passato per Dachau, e lasciando tutto in Germania, amici e averi. La sua prima tappa fu l’Inghilterra dove conobbe Herta, anche lei una rifugiata ebrea tedesca. A diciott’anni gestirono assieme una scuola estiva d’inglese, che diventò ben presto una sorta di orfanotrofio per bambini ebrei tedeschi mandati lì dai genitori prima che fosse troppo tardi. Insieme, a neanche 18 anni, si diedero il compito di portare via dalla Germania più bambini possibile.
Alla fine del ’39 Hans ricevette finalmente i visti per gli USA dove poté ricongiungersi con i membri più stretti della sua famiglia che, attraverso l’Olanda, il Trentino, la Palestina, la Svizzera, erano riusciti ad attraversare l’Atlantico. Da lì continuò a rimanere in contatto con Herta, scrivendosi delle lunghe e lentissime lettere. Negli Stati Uniti Hans finì il liceo frequentando una scuola notturna, mentre di giorno lavorava per coltivare il suo sogno di andare a studiare legge a Harvard.
Il giorno successivo al 7 dicembre del 1941 – un data che vivrà nell’infamia – ascoltò per radio il famoso discorso del Presidente Roosvelt sull’attacco Giapponese a Pearl Harbor con cui gli Stati Uniti entravano in guerra. In quanto straniero Hans non aveva doveri di leva, ma sentiva di avere un intimo debito di riconoscenza verso il Paese che aveva salvato la vita a lui e a parte della sua famiglia: sulla scorta di questa spinta ideale decise di arruolarsi come volontario nei ranghi dell’Esercito Americano, l’esercito del suo nuovo Paese che finalmente aveva preso parte, e aveva preso la parte giusta. Per non sembrare un eroe, Hans racconta che in quella decisione incise anche il fatto che ciò gli avrebbe conferito, ipso facto, l’attesa cittadinanza americana.
Una volta nell’esercito fu assegnato a un battaglione che avrebbe svolto una funzione di intelligence in Marocco, e gli furono impartite lezioni di arabo per 10 ore al giorno, da dottorandi di linguistica che non sapevano nulla d’arabo ma riuscivano a tenersi una lezione avanti ai loro studenti. Dopo un anno di questa preparazione intensiva la missione non fu approvata, e l’aver imparato alla perfezione quella lingua non gli servì mai più: altri commilitoni ne fecero una carriera, diventando commercianti con il Medio Oriente, o insegnanti di arabo all’università. Con lo smantellamento della missione in Marocco la sua frustrazione per il mancato contributo alle buone sorti di un conflitto in cui davvero credeva, crebbe a dismisura. Temendo di essere assegnato a un’altra scuola per i suoi buoni voti, chiese il permesso di segnalarsi come volontario nelle squadre dei paracadutisti.
C’era un’altra ragione per la quale fare quella scelta: a qualche mese dallo sbarco in Normandia, l’Inghilterra era il luogo dove i paracadutisti americani venivano inviati. E in Inghilterra c’era Herta. La corrispondenza con la futura moglie era diventata sempre più fitta, e la voglia di rivedersi sempre più forte. Intanto Hans aveva scalato i gradi dell’esercito per una ragione semplice: era uno dei pochissimi, lui e gli altri profughi dalla Germania, a parlare un tedesco perfetto senza accento inglese. Ciò, probabilmente, gli valse la fortuna di non essere assegnato alle prime linee per lo sbarco del 7 giugno in Normandia.
I nuovi gradi conferitigli gli diedero il diritto a una Jeep nelle ore libere con cui poté andare da Herta, centinaia di lettere, e cinque anni dopo essersi visti l’ultima volta. Si incontrarono altre due volte prima di capire che le loro vite si appartenevano l’un l’altra. La terza volta fu presente il padre di lei, che approvò entusiasticamente il loro matrimonio. Cercarono di fare tutto nel più breve tempo possibile, perché sapevano che Hans poteva essere inviato in Francia senza preavviso ciascuno dei giorni che sarebbero seguiti.
Hans fece formale richiesta ai proprî superiori – come era dovere di qualunque membro dell’esercito volesse contrarre un matrimonio – e ricevette, dal Comando del Generale Eisenhower, una risposta non proprio gradita: il permesso era concesso, ma era soggetto a un’attesa di 90 giorni. Questo era il tipico ordine, quasi procedurale, che veniva dato ai militari che chiedevano di sposarsi durante le missioni in terra estera: succedeva fin troppo spesso che delle reclute uscissero una sera con una ballerina di un paese straniero, e volessero sposarla l’indomani. Il paradosso era però che una regola istituita per i soldati che volevano sposare una ragazza conosciuta la sera prima si applicava anche a Hans, che conosceva Herta da cinque anni. C’era poco da fare: questo è l’esercito. Poco tempo dopo Hans fu assegnato a un reggimento d’intelligence della 82° Airborne Division. E sebbene nessuna delle lettere con “indicazioni sensibili” le fosse stata recapitata, Herta vide gli aerei militari passare sopra la propria testa, in direzione del mare, e capì che il suo non-ancora-marito stava volando oltre la Manica.
Non solo il danno, ma la beffa: durante i primi mesi di combattimenti nella parte di Francia appena liberata, la vicenda del mancato matrimonio era valsa a Hans le beffe di tutti i commilitoni. Potete immaginare: uno sciagurato che aveva incontrato la propria fidanzata cinque anni prima e non aveva avuto il permesso di sposarla perché la conosceva da troppo poco tempo. Era proprio il tipo di faccenda – di regolamenti pensati per delle situazioni e applicati con zelo ad altre che non lo richiederebbero – per cui era noto l’esercito, e che destavano l’ilarità dei graduati. Pane per le lingue malevole, Hans era diventato “quello che Eisenhower non vuole far sposare”. Tuttavia questa particolare notorietà non si rivelò di pieno detrimento: le tanto divertenti vicissitudini di questo ufficiale un po’ impacciato arrivarono in alto, molto in alto.
Un giorno di dicembre, Hans fu chiamato a relazionare il Comandante del Personale di Divisione. Seguì questo dialogo – immaginatelo col tono militaresco con cui lo racconta Hans: «Tenente, è ancora dell’idea di sposarsi?» «Sì, signore» «Il periodo di 90 giorni di attesa è terminato?» «Sì, signore» «Bene, c’è un pilota del comando trasporto truppe che vuole sposarsi anch’egli e ha terminato il suo periodo di attesa. Darò ordine di emettere un permesso temporaneo per l’Inghilterra e autorizzerò l’uso di un aeroplano militare a questo proposito. Il vostro compito è quello di sposarvi nel più breve tempo possibile, trascorrere qualche giorno con le vostre spose e riportare i vostri culi, e l’aeroplano, in questo preciso luogo. Decollate!» «Sì, signore. Grazie Signore».
Due giorni dopo Hans e Herta si sposarono civilmente e partirono per una breve luna di miele alla volta di Torquay, in Cornovaglia, unico posto dove il freddo del dicembre inglese potesse essere un po’ mitigato dal mare. Lì affittarono una minuscola stanza con bagno in una casa cantoniera: era piccolissima, ma era libera ed economica. Una sera poi – crepi l’avarizia – decisero di permettersi una cena, e il ballo che ne seguiva, nell’albergo più lussuoso della città: l’Imperial Hotel. Tornarono a Londra per una seconda cerimonia, quella con rito ebraico, che fu celebrata da un cappellano – cattolico – dell’Esercito Americano: era il suo dovere, e lo svolse con cura e partecipazione.
Credo che Hans sia una delle pochissime persone a essere stato sposato, nel proprio rito, da un ministro di un altro culto, e ad avere, oltre alle tante traversie, superato un veto al proprio sposalizio imposto da un futuro Presidente degli Stati Uniti: sarà per questo che quel matrimonio è durato 56 anni.
Alla fine il nostro eroe non fu impiegato in alcuna azione di copertura, ma fece diversi interrogatorî ad alti gradi delle SS o dell’esercito. In uno di questi contrattò la resa di un battaglione di diverse migliaia di tedeschi e, quale segno di capitolazione, il generale della Wehrmacht gli consegnò la pistola d’ordinanza, arma che Hans ha sempre conservato. Alla fine della guerra partecipò alla ricostruzione in Germania – ma quando gli fu offerta indietro la nazionalità tedesca, toltagli anni prima, rifiutò – poi tornò in America per continuare i suoi studî. Lui, quando racconta queste cose, specifica che il resto della sua vita fu molto più noioso.
Negli Stati Uniti si affermò come avvocato e, nel loro primo viaggio in Inghilterra, Herta e Hans tornarono a Torquay. Questa volta soggiornarono all’Imperial Hotel e replicarono il ballo di quella sera di diciassette anni prima, in una delle scene più romantiche ch’io riesca a immaginare.
–
Hans è morto ieri, accanto a Herta, un anno e mezzo dopo aver festeggiato la vittoria di Barack Obama nella sua, grande, America. Era il fratello di mia nonna. Questo è il mio piccolo pensiero per lui.
[Qui il primo: Brutti e liberi – qui il secondo: Grande Raccordo Anulare – qui il terzo: Il caso Plutone – qui il quarto: I frocioni – qui il quinto: Comunisti – qui il sesto: La rettorica – qui il settimo: Rockall – qui l’ottavo: Compagno dove sei? – qui il nono: La guerra del Fútbol – qui il decimo: Babbo Natale esiste – qui l’undicesimo: Caravaggio bruciava di rabbia – qui il dodicesimo: Salvato due volte – qui il tredicesimo: lo sconosciuto che salvò il mondo – qui il quattordicesimo: Il barile si ferma qui – qui il quindicesimo: Servizî segretissimi – qui il sedicesimo: Gagarin, patente e libretto – qui il diciassettesimo: La caduta del Muro – qui il diciottesimo: Botta di culo – qui il diciannovesimo: (Very) Nouvelle Cuisine – qui il ventesimo: Il gallo nero – qui il ventunesimo: A che ora è la fine del mondo? – qui il ventiduesimo: Che bisogno c’è? – qui il ventitreesimo: Fare il portoghese – qui il ventiquattresimo: Saluti – qui il venticinquesimo: La fuga – qui il ventiseiesimo: Dumas – qui il ventisettesimo: Zzzzzz – qui il ventottesimo: Teorema della cacca di cavallo – qui il ventinovesimo: Morto un papa – qui il trentesimo: L’invincibile Marco Aurelio – qui il trentunesimo: L’Amabile Audrey – qui il trentaduesimo: Anima pura – qui il trentatreesimo: Ponte ponente – qui il trentaquattresimo: Batigol – qui il trentacinquesimo: L’originalità del bene]