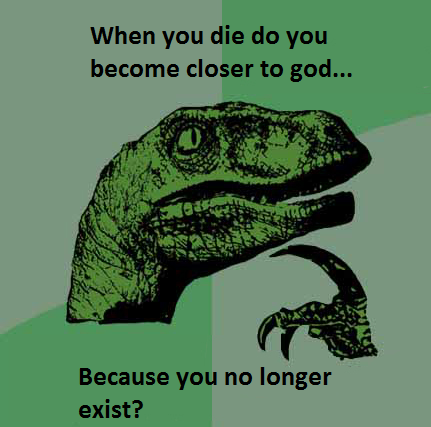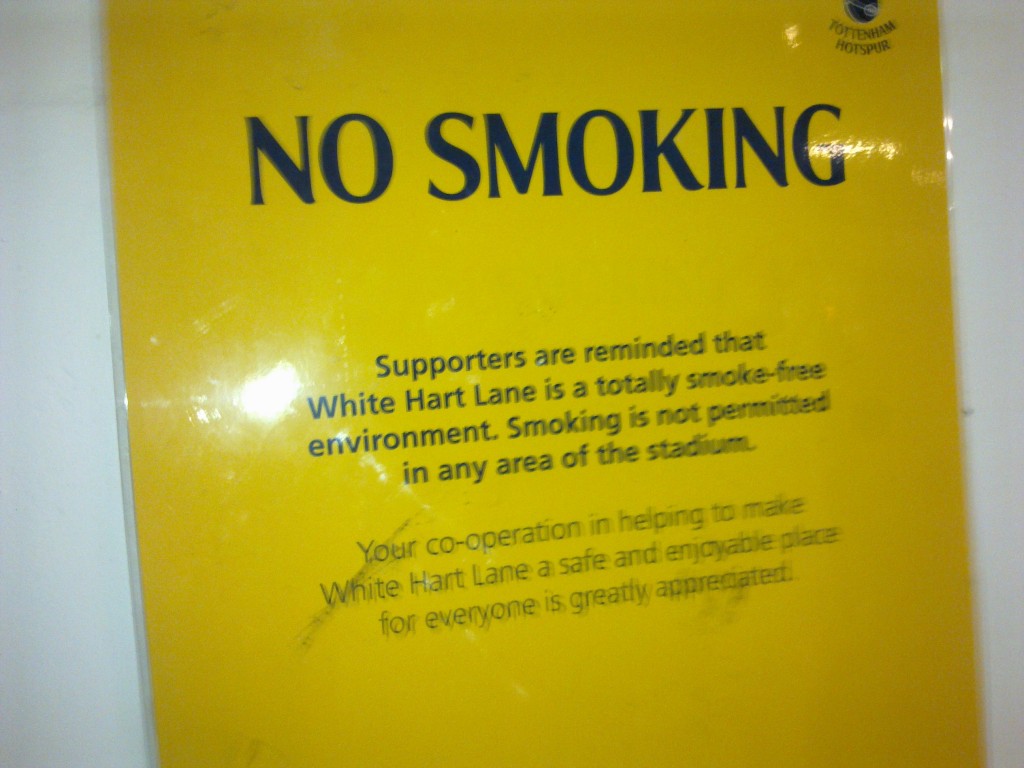interesse 3 su 5
Ci ho messo tanto per capire che non fosse giusto copiare, a scuola, durante un compito in classe.
Qualche tempo fa il mio amico Franco, che conosce il mio lambiccarmi sulle questioni etiche, mi sottopose questo racconto che aveva trovato nella rubrica di Gramellini:
Una lettrice racconta di aver ricevuto dal padre, in punto di morte, una confessione che l’ha stupita e confusa. L’anziano signore era stato un professore di latino e greco stimato e temuto da tutti per la sua intransigenza. Il classico duro capace di annullare il compito in classe allo studente sorpreso a consultare un foglietto. Ma il giorno degli esami di maturità il «prof» implacabile si trasformava nel più imprevedibile degli alleati. A turno i maturandi uscivano dall’aula per recarsi in bagno. E in un angolo buio del corridoio trovavano lui, che consegnava a ciascuno la versione già tradotta. Ma non la stessa per tutti. Una versione personalizzata e con l’handicap. I meritevoli ricevevano un testo impeccabile. I meno bravi uno sporcato da un paio di errori, che per gli scarsi salivano a quattro e per i pelandroni a cinque: al di sotto della sufficienza. Il professore comunicava a ogni ragazzo il numero di errori presenti, così anche il peggiore avrebbe potuto salvarsi, se fosse stato abbastanza bravo da trovarli.
Alla figlia, prima di morire, il vecchio ha spiegato che negli esami l’emotività gioca brutti scherzi, mentre con il suo metodo venivano riconosciuti i meriti e i demeriti accumulati durante l’anno. In sostanza quell’insegnante integerrimo metteva in piedi ogni estate una truffa con l’intima convinzione di rispettare una regola superiore di moralità. Non riesco a trovare una rappresentazione più efficace dell’essenza italiana. Una parte di me condanna quel professore. Ma dev’essere una parte norvegese o austro-ungarica, non fateci caso.
Mi chiese, Franco, cosa ne pensassi. Gli risposi questo:
Io non sono “un americano”, non valuto il rispetto della legge come un valore inviolabile. Trovo che ci siano leggi giuste e leggi sbagliate, trovo che sia accettabile non sottostare al contratto sociale e decidere di violare una regola, ovviamente assumendosene la responsabilità (è lo stato di diritto). E fin qui è facile. Ma trovo anche legittimo che, ciascuno di noi, possa concedersi rispetto alla propria stessa persona delle piccole libertà che rendano la vita più facile: l’esempio classico è il semaforo rosso. Se sono le quattro di notte, su di una strada che conosco, e vedo che a distanza di km non c’è nessuna macchina che si avvicina, beh io passo anche col rosso. Naturalmente auspico che il vigile che mi becchi mi faccia la multa, perché vorrei che si facesse così di fronte a chiunque altro, e quindi a me. Altrimenti sarebbe troppo pericoloso lasciare a ognuno – magari ubriaco e spericolato – la coscienza di decidere se si può passare con il rosso o no. Diciamo che ci sono casi in cui trovo giusto astrarsi dalla legge della maggioranza, che è l’espressione della legge: un esempio, io non sono un astensionista referendario. Se non mi piace il referendum voto “no”. Tuttavia ci sono limitati casi in cui mi comporterei diversamente: ipotizziamo che sia in gioco il referendum se istitutire la pena di morte in Italia, ecco, io considererei quel tema così importante che non andrei a votare per approfittare del possibile fallimento del quorum, in questo modo violando – con un trucco – la legge della maggioranza. Non so se tu ritieni ragionevole ciò che sto dicendo, di sicuro è molto pericoloso, e me ne rendo conto: per questo non soltanto dico che accetto, ma che auspico la multa del vigile (ovviamente io, dentro la mia macchina cercherò di non farmi beccare).
Quindi come orizzonte etico si potrebbe dire che io potrei essere propenso ad accettare la soluzione del professore. Eppure no. Capisco profondamente la sua buona fede, ma trovo che ciò che noi chiamiamo “merito” è semplicemente un dispositivo che ha trovato la società per crescere. Noi vogliamo che i più bravi ottengano dei posti non perché ci sia un ordine astrale in cui essi debbano essere premiati – in fondo uno meno capace a fare le tabelline è nato meno capace – ma perché dare a chi li fa meglio gli incarichi serve a creare una società migliore, più felice, più funzionante, anche per gli altri. Pensa ai medici, agli ingegneri, ma anche ai cantanti, ai poeti o ai cuochi: è giusto che sia cuoco chi cucina meglio perché farà felice chi sazierà. Che c’entra tutta questa premessa? Ha a che fare con quel lato emotivo – in realtà parla di debolezza emotiva, di lati emotivi ce ne sono diversi, anche quelli che ti fanno andare meglio sotto pressione – di cui parlava il professore: i ragazzi che non sanno esprimere sé stessi sotto pressione, dovranno impararlo, dovranno sforzarsi. Quella non è certamente l’ultima volta che saranno sotto pressione, anzi: molto probabilmente, qualunque ruolo nella società andranno a occupare, si troveranno di fronte a numerosissime altre prove simili. Perciò, e così, questo tipo di debolezza – o l’opposta presenza di spirito – non può non andare a incidere quanto il volume di studio, l’impegno, e il merito (personale) accumulato agli occhi del Prof. Come si dice: gli esami sono esami, ma sono anche esami di vita.
Francesco ha raccontato questa cosa qui, su come funziona il giornalismo in Italia: leggetela.
Naturalmente lo spirito giusto con cui leggerla è senza giustizialismi (e senza cornette sradicate), tenendo conto che il fair-play viene prima di tutto e che dare una mano a qualcuno che ne ha bisogno è cosa altruista – e penso che sarebbe d’accordo anche Francesco, al quale questo post non creerà tanti amici –, il problema è l’istituzione.