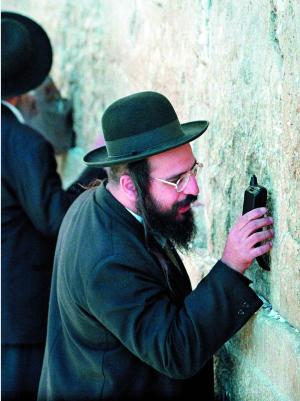Ho visto Fitna, un piccolo documentario anti-islamico attorno al quale c’era stata una querelle la scorsa primavera per la mancata messa in onda a causa della paura di ritorsioni, com’era avvenuto per Submission di Theo van Gogh. Anche su internet era stata messo, poi rimosso, poi rimesso. Lo trovate qui, dura 17 minuti, alcune immagini sono forti.
La vicenda di Submission (che invece è qui, sottotitoli in italiano) la conoscete, Theo van Gogh – il regista, e pronipote del pittore – rifiuta la scorta e viene ucciso da un estremista mussulmano, la sceneggiatrice e attrice Ayaan Hirsi Ali – anch’ella minacciata – si salva perché ha la scorta da parlamentare olandese. Il corto – invece – sarebbe la prima parte, di una seconda mai realizzata per la morte del regista. Merita due parole di più Ayaan Hirsi Ali, che è uno dei personaggi più straordinarî del nostro mondo. Ha scritto un libro (mai lapsus fu più azzeccato, avevo scritto senza volerlo “libero”), Infedele, che dovrebbero leggere tutti. Ed è anche un test. Prendete una x persona, fategli leggere l’inizio di “my freedom“, la seconda parte – se non si commuove, se non è paralizzato dalla tensione emotiva, quella x persone è fuori di dubbio un insensibile.
***
Fitna, che dall’arabo coranico si traduce come qualcosa di simile a “guerra civile”, vuole essere il presecutore naturale del corto di Theo van Gogh. Ma se Submission era una richiesta d’aiuto, un grido d’allarme, l’insieme più ruvido di queste due cose, ovvero una bestemmia, Fitna è un documento a tesi. È confezionato in maniera irritante, e ha quell’accostamento di immagini e quella melliflua scelta della musica di sottofondo che sono insopportabili in un documentario. Insomma, se non hai già un pregiudizio non ci caschi.
Mi ha ricordato molto Michael Moore. Ora, siccome – ovviamente approssimo, per schematismo – chi segue Michael Moore è piuttosto tenero con l’Islam, mi son domandato: ma come si rapportano gli uni agli altri? Cosa criticherebbe un appassionato di Bowling a Columbine a Fitna? Non sta anche quel documento – il solito ritornello – “enunciando fatti”?